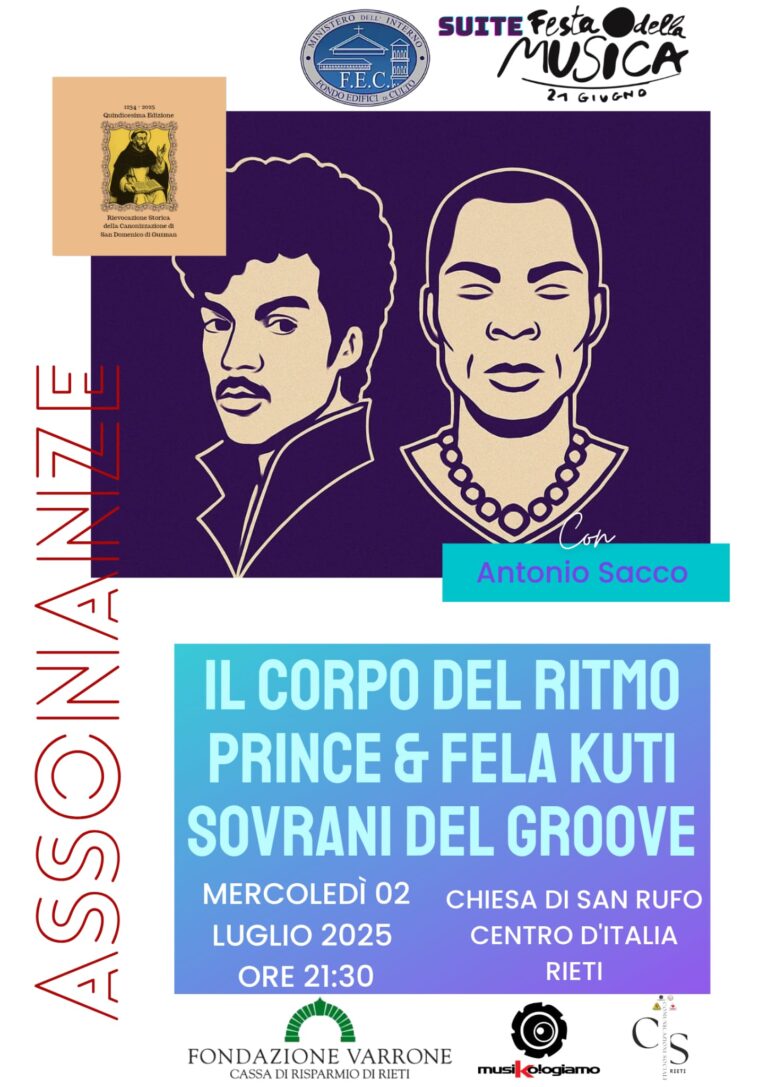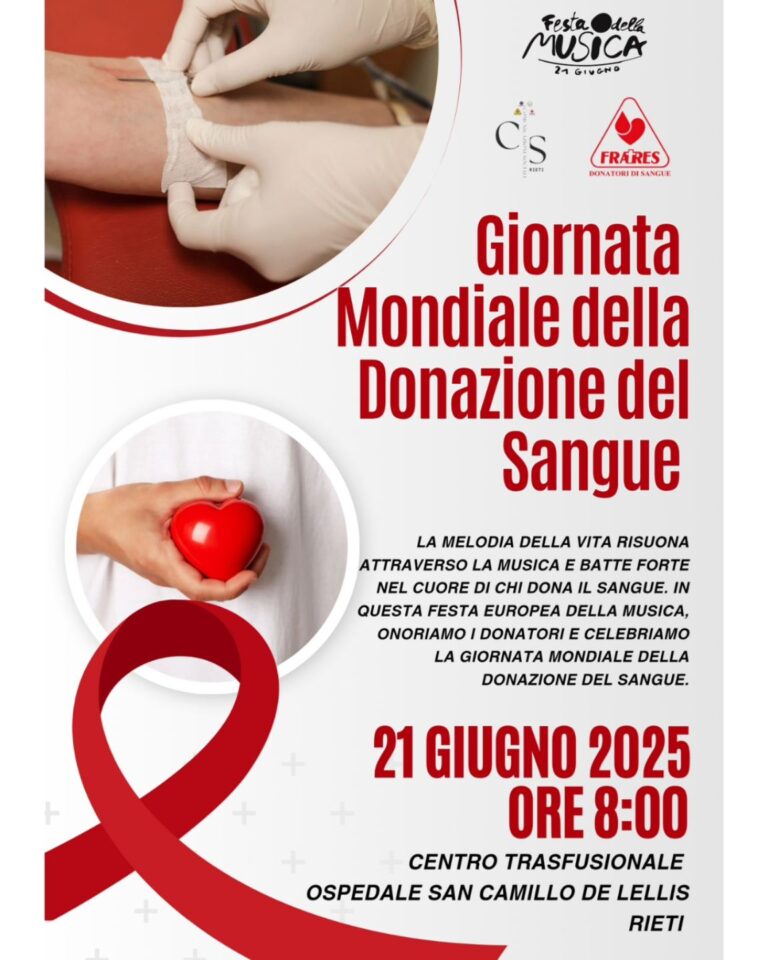Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, è stato definito l’autentica “Pasqua laica” della nuova Italia repubblicana e antifascista. Ogni anno questa data invita a una riflessione collettiva sul significato di rinascita e liberazione. È un momento in cui il Paese ricorda la fine di un lungo incubo di oppressione e celebra la resurrezione simbolica della patria: dal buio della dittatura si passò finalmente alla luce della libertà ritrovata. La portata storica ed emotiva di questo giorno fa sì che il 25 aprile non sia una semplice ricorrenza, ma un vero e proprio rito civile di memoria e identità nazionale, intrecciando fede, politica e cultura in un’unica narrazione di speranza.
Dal buio della tirannia alla speranza della Resistenza
Per oltre vent’anni l’Italia visse sotto il giogo della dittatura fascista, privata delle libertà fondamentali e trascinata nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni bui molti italiani sperimentarono cosa significhi perdere la libertà, scoprendo che “la libertà è come l’aria: si capisce quanto valga quando viene a mancare”. Dopo l’8 settembre 1943 il Paese si spezzò: l’occupazione nazista e la nascita della Repubblica di Salò inondarono l’Italia di violenze, deportazioni e terrore. Eppure, proprio in quel periodo oscuro germogliò il seme della Resistenza. Uomini e donne comuni – contadini, operai, studenti, soldati sbandati – scelsero di prendere le armi o di sostenere in ogni modo la lotta partigiana, dando vita a un vasto movimento popolare deciso a riscattare l’onore e la libertà della nazione. Molti di loro pagarono con la vita la propria scelta: sulle montagne, nelle città, nelle carceri e nei campi di concentramento, migliaia di italiani caddero “per riscattare la nostra libertà”, e fu lì che nacque la nuova Italia democratica. Il sangue dei martiri della Resistenza divenne il seme di una patria nuova, così come dal sacrificio nasce la redenzione nelle tradizioni religiose.
Non mancarono riferimenti spirituali in questa epica lotta tra oppressione e liberazione. Alcuni partigiani vissero la propria battaglia come una missione quasi sacrale, in cui il richiamo alla resurrezione era esplicito. Celebre è la Preghiera del Ribelle scritta dal giovane partigiano Teresio Olivelli, in cui invoca Dio con parole ispirate al Vangelo: «Tu che dicesti: “Io sono la resurrezione e la vita”, rendi nel dolore all’Italia una vita generosa e severa». In queste righe, concepite da un uomo pronto a dare la vita per la libertà altrui, l’anelito religioso si fonde con quello civile: la sofferenza collettiva viene offerta affinché l’Italia rinasca, proprio come il Cristo risorto dopo il Calvario. Molti resistenti, pur laici o di diverso credo, sentivano di partecipare a una sorta di passione e resurrezione nazionale: dall’oscurità della tirannia rinasceva la speranza. Quella speranza alimentò la loro forza d’animo nei giorni più difficili, rendendo la Resistenza una lotta non solo politica ma anche etica e spirituale.
L’alba del 25 aprile 1945: “Arrendersi o perire!”
Dopo mesi e mesi di combattimenti clandestini, di sacrifici e coraggio, arrivò finalmente la primavera del 1945. Mentre gli Alleati avanzavano risalendo la penisola e sfondando la Linea Gotica, i partigiani intensificavano le azioni contro gli occupanti nazifascisti. Il clima in quei giorni di aprile era carico di tensione ma anche di trepidante attesa: qualcosa di grande stava per accadere. La svolta giunse all’alba del 25 aprile 1945, quando dal Nord Italia partì l’insurrezione generale. A Milano, il futuro Presidente Sandro Pertini, allora esponente del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, lanciò attraverso la radio un proclama storico:
«Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. […] Ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire.»
Queste parole risuonarono come una tromba della liberazione in tutta la città. Il popolo milanese – e presto quello di molte altre città del Nord – raccolse l’appello: i partigiani scesero dalle colline e comparvero nelle strade, mentre operai e cittadini insorsero occupando punti nevralgici, disarmando i presidi fascisti ancora rimasti. A Genova e Torino i resistenti avevano già avviato la sollevazione nei giorni immediatamente precedenti, e ora l’insurrezione dilagava ovunque. Ovunque sventolava il tricolore, nascosto e custodito gelosamente per anni, ora finalmente libero di tornare a splendere al sole.
In poche ore molte città del settentrione si scrollarono di dosso l’oppressore. I comandi nazisti, colti di sorpresa e ormai in ritirata, trattavano la resa o venivano sopraffatti. Persino il Duce, Benito Mussolini, in quelle ore disperate tentò la fuga travestito da soldato tedesco: lascerà Milano proprio il 25 aprile, diretto verso una vana salvezza, solo per essere catturato dai partigiani pochi giorni dopo, mettendo fine a vent’anni di tirannide. Il mito del fascismo crollava definitivamente, trascinato via dalla storia insieme alle macerie della guerra.
La gioia della Liberazione: un popolo risorge
Quella giornata memorabile di aprile assunse presto i contorni di una festa improvvisa e commossa. “Che emozione, la libertà”, scrisse un cronista milanese nel descrivere quelle ore. Dopo tanti anni di paura, finalmente la notizia tanto attesa correva di bocca in bocca: la guerra è finita! Le campane delle chiese cominciarono a suonare a festa, come in un giorno di Pasqua, mentre folle di persone si riversavano nelle strade col tricolore in mano e nel cuore la speranza di riabbracciare presto i propri cari lontani. In ogni piazza esplosero abbracci e canti liberatori; sconosciuti si stringevano come fratelli, uniti dalla gioia incontenibile di sentirsi di nuovo liberi. Molti intonarono canzoni fino ad allora proibite: su tutte, Bella ciao, il canto dei partigiani, le cui strofe riecheggiavano come un inno di rinascita. «Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l’invasor…» risuonavano le parole ormai liberatorie. Da quel giorno, questa canzone sarebbe divenuta il simbolo stesso della Liberazione, cantata ogni 25 aprile in tutta Italia per celebrare la libertà riconquistata.
In quei momenti, la Pasqua di resurrezione e la liberazione terrena si fusero in un’unica esperienza emotiva. La primavera del 1945 divenne per gli italiani una stagione di rinascita: ai fiori nei campi e nei giardini corrispondeva una nuova fioritura civile. Come la pietra rotolata via dal sepolcro nel Vangelo, così le macerie morali e materiali del fascismo venivano rimosse, lasciando entrare la luce. Il 25 aprile fu vissuto da molti come un nuovo inizio, una pagina bianca su cui scrivere il futuro dopo anni di buio. Dalla guerra si passava alla pace, dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita – non solo in senso metaforico, ma concreto. Il popolo italiano, provato ma non vinto, quel giorno “risorse” come comunità nazionale libera e democratica. Nel sorriso dei bambini tornati a giocare per strada, nelle lacrime degli anziani che avevano visto troppe sofferenze, si poteva scorgere la stessa luce di speranza che, per i credenti, illumina il mattino di Pasqua.
Dalla Liberazione alla democrazia: il paese rinasce
La Liberazione del 25 aprile 1945 non segnò soltanto la fine di un regime e di un conflitto: fu l’atto di nascita di una nuova Italia. Subito dopo la guerra, il popolo italiano fu chiamato a costruire dalle macerie un edificio politico e sociale inedito, fondato sui valori per cui tanti partigiani avevano lottato. Già l’anno seguente, il 22 aprile 1946, su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il Luogotenente del Regno Umberto II di Savoia emanò un decreto che sanciva ufficialmente: «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale». Pochi mesi dopo, il 2 giugno 1946, gli italiani – donne finalmente incluse – si recarono alle urne in una storica consultazione popolare. Con un referendum sancirono la fine della monarchia complice del fascismo e la nascita della Repubblica. Nello stesso giorno elessero un’Assemblea Costituente incaricata di dare al paese una nuova carta fondamentale.
Il legame tra la Liberazione e la nuova Costituzione repubblicana fu profondo e immediato. I principi di libertà, uguaglianza e giustizia sociale che animarono la Resistenza divennero l’ossatura del testo costituzionale entrato in vigore il 1° gennaio 1948. Come ricordò efficacemente il giurista Piero Calamandrei, dietro ogni articolo di quella carta “ci sono giovani come voi, fucilati, impiccati, caduti nelle montagne o morti nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata la nostra Costituzione”. La Costituzione repubblicana fu dunque figlia diretta del 25 aprile: nata dal sacrificio di centomila caduti e dal risveglio morale di una nazione intera, essa rappresentò la codifica della rinascita italiana in valori e diritti destinati a durare nel tempo. In virtù di quel fondamento, l’Italia poté risollevarsi dall’abisso e presentarsi al mondo con dignità ritrovata. “La Resistenza contro il nazifascismo – ha sottolineato il Presidente Sergio Mattarella – contribuì a risollevare l’immagine e a recuperare il prestigio del nostro Paese. Fu a nome di questa Italia risorta che Alcide De Gasperi poté presentarsi a testa alta alla Conferenza di pace di Parigi. Questo riscatto, il sangue versato, questo ritrovato onore nazionale lo celebriamo oggi.” Le parole del Presidente, pronunciate a distanza di ottant’anni, ribadiscono come la Liberazione resti il fondamento dell’identità democratica italiana: un riscatto collettivo che diede nuova vita alla nazione.
Memoria collettiva e riti civili: l’eredità del 25 aprile
Da quel 1945 ad oggi, il 25 aprile è divenuto per gli italiani molto più che una semplice data storica – è un patrimonio di memoria collettiva e un pilastro dell’identità nazionale. Ogni anno, generazione dopo generazione, la sua celebrazione rinnova il patto ideale stipulato tra i caduti di ieri e i vivi di oggi. In ogni città e paese d’Italia, dal Nord al Sud, il 25 aprile si svolgono cerimonie ufficiali e manifestazioni popolari per onorare il sacrificio dei partigiani e ribadire l’importanza dei valori democratici conquistati con la Resistenza. Le autorità depongono corone d’alloro nei luoghi della memoria – monumenti, lapidi, cippi partigiani – accompagnate spesso dalle note del Silenzio e dell’inno nazionale. Nelle piazze risuonano discorsi commemorativi e canti come “Bella ciao”, intonati non solo dai cori ma spesso da tutta la comunità all’unisono, in un abbraccio ideale tra passato e presente. Questi riti civili – la parata dei gonfaloni comunali, le bandiere tricolori sui balconi, il corteo che sfila magari sotto la pioggia primaverile – costituiscono una vera liturgia laica annuale della Repubblica, attraverso cui il Paese ricorda, rivive e rinnova i valori fondanti della propria libertà.
La memoria del 25 aprile è anche fatta di volti e di storie tramandate. I pochi partigiani ancora in vita, ormai molto anziani, partecipano quando possono alle celebrazioni raccontando ai più giovani la propria esperienza, affinché il ricordo rimanga vivido e significativo. Nelle scuole si insegna ai ragazzi cosa avvenne in quel lontano 1945, affinché comprendano che la libertà di cui godono ebbe un prezzo altissimo e che spetta a loro custodirla. In molte famiglie italiane si conservano gelosamente lettere dal fronte, fotografie sbiadite di un nonno con il fazzoletto partigiano al collo, medaglie al valore: frammenti di memorie private che compongono il grande mosaico della memoria nazionale. Così, la storia della Liberazione non è un racconto astratto, ma vive nei ricordi tramandati e nei riti condivisi ogni anno.
Ogni 25 aprile, l’Italia intera – pur con le sue divisioni politiche e generazionali – indossa il tricolore della gratitudine e della speranza. È un giorno per ringraziare chi combatté allora, ma anche per riflettere sul presente e sul futuro: le sfide della democrazia, la necessità di vigilare contro ogni rigurgito di odio e autoritarismo, l’importanza di restare uniti nei valori costituzionali. La Festa della Liberazione è perciò un ponte tra passato e futuro, un momento in cui la nazione si guarda allo specchio delle proprie radici antifasciste per trovare la direzione verso un domani di pace. Il 25 aprile “segnò la fine del nazifascismo e la riconquista della libertà in Italia”, e da allora simboleggia la capacità di un popolo di risollevarsi dalle ceneri più oscure.
In questo senso profondo, il 25 aprile è davvero una Pasqua di rinascita civile: come nella liturgia pasquale si rinnova ogni anno la fede nella vittoria della vita sulla morte, così ogni anno in Italia si rinnova la fede nella vittoria della libertà sulla tirannia. Nell’osmosi simbolica tra Pasqua e Liberazione, la resurrezione non è soltanto un dogma religioso ma diventa metafora tangibile di un popolo che risorge. E il messaggio universale che scaturisce da questa giornata è che la libertà, una volta conquistata, va difesa e coltivata con cura. Come recita un motto ormai entrato nel lessico civile italiano: ora e sempre Resistenza. In quelle tre parole – semplici ma potentissime – è racchiuso l’impegno di ieri, di oggi e di domani: custodire la memoria del passato e testimoniare, con la vita quotidiana di ciascuno, i valori per cui il 25 aprile 1945 un’intera nazione è rinata.
“Il 25 aprile”, in definitiva, “rappresenta per il nostro paese un momento di svolta e di rinascita”. È la storia di una trasformazione collettiva: dal silenzio imposto alla voce ritrovata, dalla paura alla dignità, dalla morte alla vita. È la festa di tutti coloro che credono nella libertà e nella democrazia, un racconto corale che continua a essere scritto ogni anno, ogni volta che un italiano ricorda e celebra quei giorni del 1945. In quell’abbraccio ideale tra generazioni, in quella gratitudine che s’innalza come canto, vive lo spirito eterno della Liberazione. Buon 25 Aprile: possa il ricordo di quella rinascita continuare ad illuminare il cammino della nostra comunità, oggi come allora.
Ora e sempre, Libertà.